|
Non
sarà
fuori
luogo
dedicare
un
piccolo
spazio
all'esame
che
la
teoria
dell'armonia
delle
sfere
occupa
nella
Divina
Commedia
di
Dante,
ed
in
particolare
nel
Paradiso:
essa
infatti
appare
tutt'altro
che
scontata,
ed
anzi
per
molti
versi
altamente
problematica.
Dante
accoglie
l’armonia
delle
sfere
discostandosi
dal
dettato
del
maestro
Aristotele
(De
Caelo
II,
9),
sulla
base
dell’auctoritas
di
Severino
Boezio
(V-VI
secolo
d.C.),
ma
soprattutto
di
quanto
sull’argomento
era
stato
detto
dallo
«spirito
magno»
Cicerone
nel
Somnium
Scipionis.
Qui
infatti
Scipione, relativamente alla musica
celeste, si domanda:
quis est, qui complet aures meas tantus et tam dulcis
sonus?
("che suono
è
questo
che
riempie
le
mie
orecchie,
così
intenso
e
così
dolce?").
Oltre a qualificare il sonus sia
quantitativamente (tantus) che qualitativamente (tam
dulcis), Cicerone si sofferma a lungo ad indagare
la teoria dell’armonia delle sfere, dimostrando di essere pienamente
a conoscenza
della letteratura tecnica sull’argomento.
L’esistenza
dell’armonia
delle
sfere
era
stata
negata
da
Aristotele
e
dai
suoi
commentatori,
tra
cui
Averroé,
Alberto
Magno
e
Tommaso
d’Aquino.
In un primo momento, Aristotele illustra la teoria
pitagorica qualificandola come gradevole ed interessante, anche se falsa. È egli
stesso a riportare la giustificazione attribuita ai pitagorici del perché non
udiamo la celeste armonia: perché un suono o un rumore non vengono percepiti se
non in contrasto con il proprio opposto, il silenzio o meglio l’assenza del
suono medesimo; dal momento che quello prodotto dalla rotazione delle sfere
planetarie è un suono che ci è presente sin dalla nascita, non è possibile
riconoscerlo, in quanto ci manca la percezione del suo contrario. Una
saturazione per assuefazione, simile a quella provata dai fabbri che appaiono
indifferenti al rumore provocato dalla propria quotidiana attività lavorativa.
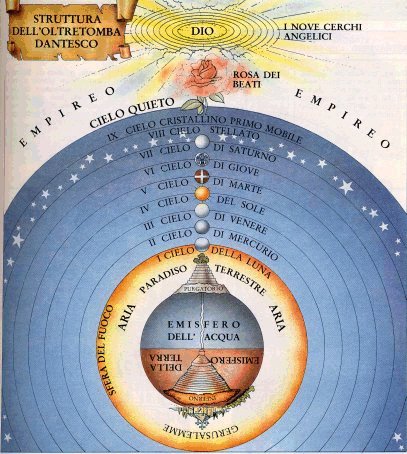
La
struttura
del
cosmo
dantesco
La posizione propria di Aristotele
è
tuttavia
recisa nel
negare l’armonia delle sfere: alla domanda perché non udiamo la musica delle
sfere risponde perché non c’è nessuna musica, di più, non c’è nemmeno nessun
rumore. Non si sofferma qui su tecnicismi musicali, non gli interessa avanzare
ipotesi su presunte qualità celestiali o cacofoniche del suono: non esiste
nessuna musica, ed è facilmente dimostrabile, per assurdo: se esistesse un suono
prodotto dalla rotazione degli astri, sarebbe talmente forte ed intenso da
distruggere la vita sulla terra, cosa che non è. Quindi, non esiste alcuna
musica delle sfere.
Ma perché non esiste? Perché gli astri si muovono nel medium
della propria sfera, e quindi non c’è attrito.
Che
cosa,
dunque,
induce
Dante
all'audace
scelta
di
opporsi
al
"maestro di color che sanno” (Inf., IV 131),
oltre
che
a
San
Tommaso?
Non
solo
un
motivo
di
ordine
estetico,
ma
anche
profonde
convinzioni
di
natura
filosofica:
non
bisogna
infatti
dimenticare
la
persistenza
nell’opera
dantesca
dell’eco
della
corrente
di
pensiero
pitagorico-platonica
(cfr.
Paolo Vinassa De Regny,
Dante
e Pitagora, I Quaderni de l’Antologia, Milano, Gioacchino Albano editore,
1955),
mediata
principalmente
dall’insegnamento
di
Boezio,
Sant’Agostino
e
San
Bonaventura.
Giulio
Ferroni
sostiene
che
«la
filosofia
di
Dante
non
propone
novità
speculative,
ma
contempera
prospettive
diverse»
(Storia della
letteratura italiana (vol I. Dalle origini al quattrocento), Milano, Einaudi
scuola, 1991, p.193). Ebbene, l’idea
del
contemperare,
così
caratteristica
dello
spirito
della
Commedia,
è
scopertamente
legata
all’area
semantica
musicale.
L’incontro
di
Dante
personaggio
con
la
musica
delle
sfere
avviene
entro
i
primi
cento
versi
del
Paradiso,
nel
momento
in
cui
egli
varca
assieme
a
Beatrice
la
sfera
del
fuoco
per
entrare
nel
primo
cielo,
quello
della
Luna
(Par
I,
76-81):
Quando
la
rota,
che
tu
sempiterni
Desiderato,
a
sé
mi
fece
atteso,
Con
l’armonia
che
temperi
e
discerni,
Parvemi
tanto,
allor,
del
cielo
acceso
De
la
fiamma
del
sol,
che
pioggia
o
fiume
Lago
non
fece
mai
tanto
disteso.
L’armonia
che
temperi
e
discerni
è
espressione
tecnica
e
musicale:
temperare
indica
qui
l’atto
dell’accordatura
(tipico
soprattutto
di
uno
strumento
a
corde
come
la
lira,
cfr.
le
sante
corde/
che
la
destra
del
cielo
allenta
e
tira
di
Par
XV,
5-6),
mentre
nell’espressione
discerni
sarebbe
secondo
alcuni
commentatori
ravvisabile
un
preciso
riferimento
alla
discretezza
dei
numeri
per
mezzo
dei
quali,
secondo
la
teoria
pitagorica,
vengono
stabiliti
i
rapporti
matematici
che
organizzano
lo
spazio
sonoro
(il
tecnicismo dell’espressione viene
sottolineato da Nino Pirrotta nel saggio «Dante
musicus: gothicism,
scholasticism, and music» in: Speculum. A journal of Mediaeval studies,
vol.XLIII, Cambridge Massachusetts, 1968, pp.245-257).
Dante
anti-aristotelico,
quindi
(almeno
su
questo
punto)?
I
pareri
dei
critici
sono
molto
discordi.
La soluzione, che
permette di aggirare l’ostacolo della confutazione di
Aristotele, arriva proprio da un aristotelico, Simplicio, il cui commento greco
al De Caelo
fu tradotto in latino da Guglielmo di Moerbeke nella seconda metà del
XIII secolo. Simplicio sposta l’attenzione dall’udibilità della musica in
sé, attorno alla quale ci si interrogava con gli strumenti della scienza
acustica del tempo, allo stato ricettivo in cui è richiesto di porsi
all’ascoltatore.
Per Simplicio
la musica delle sfere non va intesa
in senso letterale, come una vibrazione propagantesi nell’aria che colpisce l’udito umano, ma come
un atto intellettivo, attraverso il quale l’uomo accede alla comprensione dei
rapporti armonici che regolano la struttura ordinata dell’universo. Ed è proprio questa sfumatura che verrà
ripresa da Dante che, nonostante le confutazioni mosse da Tommaso, non rinuncerà
ad inserire nel suo paradiso un tale concento dei cieli: l’armonia delle sfere
non va tanto ascoltata, a seguito di una percussione dell’onda sonora, quanto
piuttosto
riconosciuta con un atto intellettivo.
(Fonti:
http://it.wikipedia.org/wiki/Musica_delle_sfere
http://brunelleschi.imss.fi.it/galileopalazzostrozzi/sezione/LarmoniaSfere.html
http://users.unimi.it/~gpiana/dm5/dm5dancr.htm
http://www.cosediscienza.it/metodo/05_teorie.htm)
|